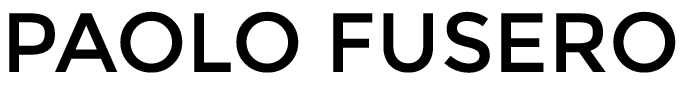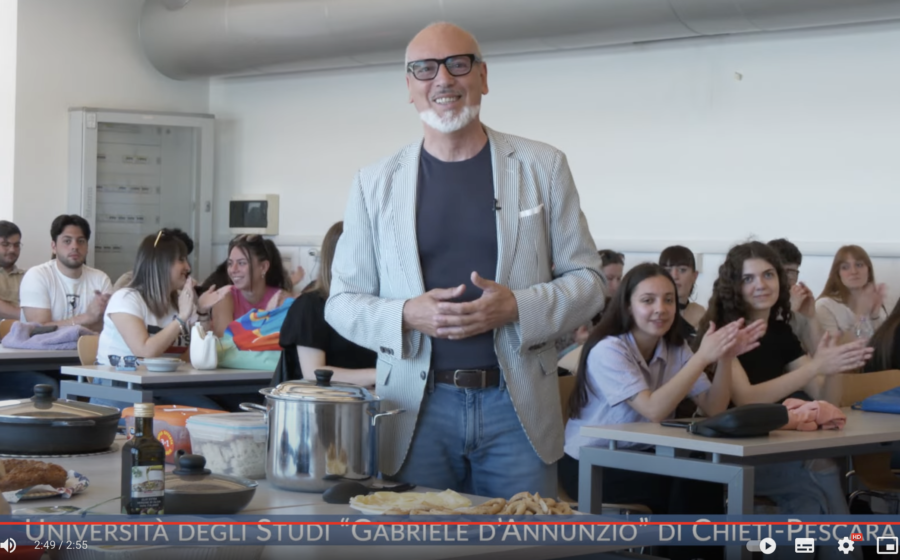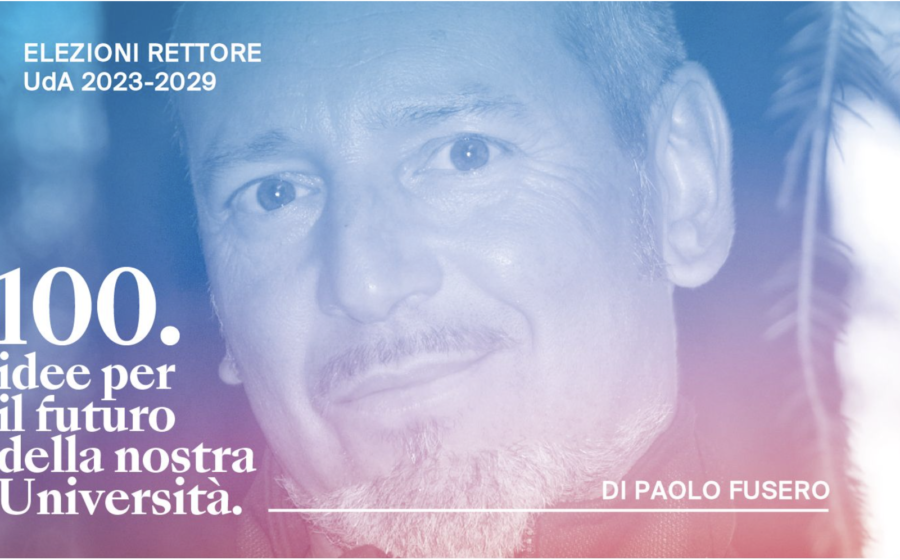“LE CITTA’ COME I SOGNI SONO FATTE DI DESIDERI E DI PAURE” … La Strada Parking di Pescara
La vicenda trentennale
Trent’anni fa la dismissione della vecchia linea ferroviaria che tagliava in due la città donò a Pescara un’opportunità meravigliosa: disporre del vecchio tracciato ferroviario per un utilizzo pubblico. La nuova strada che si venne a realizzare fu denominata “Via Castellamare Adriatico”, ma tutti la ribattezzarono “Strada Parco” per la rigogliosa presenza di piante ed alberi ai suoi lati, ma soprattutto per il ruolo identificativo che venne fin da subito ad assumere, diventando meta privilegiata di pedoni, ciclisti, anziani e bambini. Come in una metamorfosi ovidiana la linea che divideva si stava trasformando nell’asse che unificava.
La vicenda si cominciò a complicare, quando nei primi anni novanta le amministrazioni comunali di Silvi, Città S. Angelo, Pescara e Francavilla ottennero un finanziamento di circa 60 miliardi di lire per la realizzazione di un sistema metropolitano di filobus pubblici su sede protetta e la Strada Parco fu individuata come possibile tracciato. È in quel momento che iniziarono le prime manifestazioni di dissenso da parte dei cittadini che in breve tempo si organizzarono in comitati allo scopo di opporsi al progetto. Il conseguimento del finanziamento e le successive modifiche al progetto originario, determinate in parte da oggettive condizioni di irrealizzabilità e in parte dalle proteste dei cittadini, diedero luogo ad una successione di scelte amministrative che alla prova dei fatti si sono rilevate inefficaci se non addirittura contraddittorie, prova ne sia che dopo trent’anni la questione della Strada Parco è ancora aperta.
Sarebbe interessante sgomberare il campo dai pregiudizi e analizzare scientificamente i motivi che hanno trasformato l’acquisizione di un finanziamento pubblico da un fattore di merito ad un problema collettivo, generando un forte effetto NIMBY e determinando un impasse politico che da allora è divenuto una costante spina nel fianco delle amministrazioni pubbliche di ogni colore che si sono succedute in città. E’ come se il complesso iter amministrativo per l’ottenimento del finanziamento avesse gradualmente allontanato le soluzioni ideali (da un punto di vista sociale), dalle soluzioni possibili (da un punto di vista tecnico-politico), facendo rientrare questo caso di studio tra gli esempi poco virtuosi di utilizzo di fondi pubblici.
Oggigiorno le questioni sul tappeto sono almeno due: l’utilizzo della strada parco nell’immediato ed il suo ruolo nel sistema urbano di mobilità sostenibile nel medio-lungo periodo.
Strada Parking?…
Come ogni anno con la stagione estiva gli amministratori pubblici pescaresi sono chiamati a dare una risposta su come soddisfare la bulimia di parcheggi per raggiungere gli stabilimenti balneari soprattutto da parte dei residenti nella cintura collinare metropolitana. L’amletico dubbio è sempre lo stesso: utilizzare o meno la strada parco come parcheggio estivo a pagamento. I proprietari degli stabilimenti balneari spingono verso questa soluzione; i comitati della strada parco e le associazioni ambientalistiche si oppongono. Siccome ambedue le fazioni rappresentano bacini elettorali consistenti, gli amministratori non sanno che pesci prendere. Ed è proprio questo il punto: avere chiare le idee sul modello di città che si vuole perseguire.
E’ evidente che non ci possano essere soluzioni ottimali in assoluto, ma che la bontà delle decisioni sia in relazione alle priorità che si vogliono assumere. Si ha come obiettivo facilitare l’accessibilità dell’auto privata ai principali poli di attrazione economica della città? Allora va bene la “strada parking”! Si vuole perseguire un’idea di città ecosostenibile basata su un sistema di “soft mobility”? Allora le auto sulla strada parco non sono accettabili! In ambedue le opzioni però bisogna comprendere bene vantaggi e svantaggi, progettare soluzioni sistematiche adeguate (a breve e a lungo termine) e operare uno sforzo comunicativo che possa far comprendere le strategie adottate contribuendo a modificare le abitudini e i comportamenti dei cittadini. Ma soprattutto bisogna pensarci in tempo e non considerare il problema solo in fase emergenziale (che anche quest’anno sarebbe arrivata l’estate penso si potesse prevedere…!).
… No grazie!
La mia posizione personale sull’argomento, è netta: ritengo un errore trasformare la strada parco in un parcheggio, seppur temporaneo, perché significa non aver compreso l’enorme fortuna che ci è capitata a seguito della defunzionalizzazione del vecchio tracciato ferroviario. Pescara e Montesilvano grazie a quella dismissione si sono trovate in mano – come fosse piovuto dal cielo – un corridoio ecologico potenziale di livello internazionale paragonabile ad altri esempi di greenway europee. Se si hanno esigenze, comprensibilissime, di aumentare la dotazione di parcheggi estivi per facilitare un bacino di utenza che va ad alimentare le attività economiche balneari, si possono mettere in campo soluzioni alternative. Mi pare che alcune proposte in tal senso ci siano state, ad esempio quella di organizzare un servizio di bus navetta (meglio sarebbe se fossero elettrici e di piccole dimensioni… ma per adesso accontentiamoci!) che percorrendo la strada parco in un’unica direzione di marcia da sud a nord formino un anello con il lungomare collegando le spiagge ai parcheggi scambiatori (in primo luogo la aree di risulta della stazione, ma io direi anche i parcheggi delle Naiadi, quello della Stella Maris e del cinema multisala di Montesilvano, e forse anche altri). Ci si potrebbe addirittura spingere oltre e dire che si potrebbe pensare che il senso unico di percorrenza dell’anello dei bus navetta potrebbe invertirsi nell’arco della giornata in ragione dell’origine-destinazione dei flussi di traffico, per aumentare la velocità commerciale del servizio… ma non esageriamo. In ogni caso ciò consentirebbe alla strada parco di poter mantenere il suo ruolo primario di corridoio verde per pedoni e ciclisti garantendo al tempo stesso la possibilità di un trasporto pubblico adeguato e compatibile con le caratteristiche del tracciato.
Desideri e paure
Vi invito a seguirmi in un ragionamento. La risposta tradizionale alla richiesta di migliorare l’accessibilità ai centri urbani è sempre stata l’aumento dell’offerta di infrastrutture: più strade, più parcheggi. In questo modo le politiche urbanistiche italiane hanno governato il boom economico del dopoguerra dando inizio alla stagione delle grandi opere infrastrutturali e dei grandi piani di espansione delle città. Oggigiorno però le condizioni sono radicalmente cambiate e l’equazione “più infrastrutture = meno traffico” non torna più! Ci si è resi conto che superata una certa soglia nell’utilizzo dell’auto privata, la necessità di infrastrutture non aumenta più in modo lineare, ma in modo esponenziale e quindi la corsa al soddisfacimento della domanda può diventare una corsa surreale che vede continuamente spostarsi in avanti la linea del traguardo. In pratica una maggiore disponibilità di infrastrutture e di parcheggi induce un maggior utilizzo dell’auto privata: il gatto che si morde la coda!
La maggiore sensibilità verso le tematiche ecologico ambientali, la grande sfida alle cause dei cambiamenti climatici, i costi (non solo in termini economici) dei sistemi di mobilità tradizionale, hanno reso necessario un cambio di paradigma nei trasporti e nelle modalità di accesso della maggior parte delle capitali occidentali. A Copenhagen, Amsterdam, Strasburgo i sistemi alternativi pubblici e privati per il tragitto casa-lavoro sono di gran lunga più diffusi dell’utilizzo dell’auto privata. A nessun abitante di NY verrebbe in mente di andare a Manhattan in auto! A Londra si progettano grattacieli come lo Shard di Renzo Piano che attraggono decine di migliaia di persone al giorno, ma non prevedono posti auto.
E’ ovvio che ciò sia possibile perché in queste città vi è un servizio pubblico di trasporto performante e vi sono reti ciclopedonali integrate che possono effettivamente considerarsi concorrenziali all’utilizzo del mezzo di trasporto privato. Ma l’esperienza ci dice che questi modelli (che sono culturali prima ancora che infrastrutturali) saranno molto probabilmente adottati anche da noi: è solo una questione di tempo e di ricambio generazionale. Perché ciò sia possibile è necessario però che fin da ora i sistemi di trasporto pubblico siano incentivati e al tempo stesso sia disincentivato l’utilizzo dell’auto privata. I comportamenti virtuosi devono essere indotti da politiche virtuose capaci di attenuare le iniziali resistenze al cambiamento insite nella natura umana attraverso alternative valide, strategie convincenti e campagne comunicative efficaci.
Insomma… anche in questo caso siamo chiamati ad un salto culturale, non certo indolore, rispetto a dei comportamenti consolidati. Ma come scriveva Calvino “le città come i sogni sono fatte di desideri e di paure”, che noi possiamo affrontare avendo ben chiara la meta da raggiungere! E qui – ahimè – ritorniamo al punto di partenza: quale idea di città vogliamo perseguire?